28 Nov Towards a newer white cube: Appunti sul paradigma della fiera d’arte
- L’ideologia che governa lo spazio della fiera – prima almeno che la pandemia di Covid-19 avviasse un ridisegno del sistema dell’arte contemporanea, tuttora in corso – rappresenta in un certo senso la quintessenza del white cube emblematicamente illustrato da Brian O’Doherty: un luogo separato dall’esterno attraverso una serie di dispositivi (quali le pareti bianche, la pavimentazione in legno o moquette, la chiusura di finestre, ecc.) in cui “l’arte è libera, come si dice, ‘di prendere vita’”; uno spazio “senza ombre, bianco, pulito, artificiale”, in cui l’opera appare “non toccata dal tempo e dalle sue vicissitudini”[1]. Tale caratteristica di atemporalità è connessa – come nota Thomas McEvilley – alla dimensione economica dell’opera d’arte, in quanto “assicurazione di buon investimento”[2]. È pertanto comprensibile che tale ideologia venga replicata e riadattata nella definizione del paradigma espositivo commerciale per eccellenza, quello della fiera d’arte.
- Questo prototipo è stabilito fin dalle origini della fiera d’arte contemporanea, nella seconda metà degli anni Sessanta del Novecento. Come ricostruisce Christine Mehring, quello che è considerato il primo esempio in questo campo – KUNSTMARKT 67 a Colonia – inaugura “un modello che rimane sorprendentemente vicino ai suoi attuali successori, che così spesso strombazzano le loro innovazioni commerciali ed estetiche”[3]. Nato nel 1967 dall’iniziativa congiunta dei mercanti Rudolf Zwirner e Hein Stünke, l’evento raccoglie diciotto gallerie tedesche che presentano più di duecento artisti presso il Gürzenich, sala cerimoniale della città tedesca. La planimetria che riproduce quella della via commerciale (Ladenstrasse), con la teoria di stand delimitati da pareti temporanee, costituisce il carattere determinante della logica espositiva, derivante dal precedente della fiera antiquaria. La natura dichiaratamente commerciale dell’impresa si risolve in un deliberato abbandono dell’aura dell’opera d’arte, come riconosce Zwirner, “allo scopo di vendere veramente per qualche giorno… Abbiamo scelto il nome KUNSTMARKT molto consapevolmente!”[4]; una concezione che riconduce alla filosofia commerciale warholiana della Factory.
- Pur nella continuità di fondo di questo archetipo, la fiera ha percorso una parallela traiettoria di uscita dalla dimensione restrittiva del white cube: un ampio ventaglio di proposte alternative – dalle fiere satellite concomitanti ai programmi espositivi diffusi nella città ospitante – l’hanno portata fuori dai luoghi deputati. Anche questa opzione può farsi risalire all’episodio fondativo appena ricordato. Essendo stata respinta la sua richiesta di partecipazione a KUNSTMARKT 67, il gallerista di Monaco Heiner Friedrich affitta uno spazio espositivo nelle vicinanze in cui presenta una selezione di artisti della propria scuderia, convinto che “la soluzione costruttiva sia una dimostrazione di non-partecipazione piuttosto che una querela o un lamento”[5] (Demonstrative 67 è appunto il titolo dell’iniziativa).
In questi casi, la contrapposizione alla fiera “principale” avviene primariamente attraverso la scelta di spazi espositivi non canonici o connotati: luoghi spesso in disuso che avvicinano tali eventi alla logica della mostra. Queste possibilità sembrano assecondare quella “legge proiettiva” del modernismo individuata da O’Doherty secondo la quale “il contesto diventa il contenuto”[6]. - Il paradigma fieristico sta subendo con ogni probabilità la più grande svolta nella sua storia a causa della recente pandemia di Covid-19. Non sembra ancora possibile, nel momento in cui si scrive, uscire dalle strettoie della cronaca per ogni ipotesi critica che voglia misurarsi con le implicazioni dell’emergenza sanitaria sul sistema dell’arte. La fiera costituisce uno dei contesti maggiormente interessati da questa congiuntura senza precedenti: le dinamiche sociali di assembramento e la mobilità globale sono due fra le criticità maggiormente ricorrenti nella retorica che ha accompagnato questo periodo. Ciò ha determinato un ripensamento sistemico, con uno spettro di soluzioni che va dalla cancellazione alla completa migrazione digitale (le viewing rooms online come risposta ubiqua), accanto al recupero di forme ridotte di presenza o ancora l’ibridazione fra varie modalità.
- La logica emergenziale che continua a dominare costituisce un’ulteriore possibilità di ridefinizione del paradigma della fiera. Le misure prevalentemente adottate finora hanno privato del contatto fisico con l’opera d’arte (e con il suo autore). Da questa prospettiva, l’esplosione nell’utilizzo delle piattaforme digitali costringe a un tipo di fruizione indirizzata agli aspetti più smaterializzati dell’oggetto artistico, che da un lato presenta certamente grandi potenzialità (ancora davvero da esplorare), dall’altro è appiattita su una dimensione parziale, priva della prossimità insostituibile con l’opera d’arte. In questo, l’emergenza ha enfatizzato la tendenza ‒ già ampiamente in corso ‒ a una sempre più prepotente mediazione tecnologica. Per molti versi, questa potrebbe essere intesa come una forma più radicale di white cube, nella quale il processo di assolutizzazione dell’opera è portato a un grado estremo di riduzione a pura immagine, fruibile unicamente attraverso la mediazione di uno schermo. La “tecnologia dell’estetica” di cui O’Doherty discuteva nel saggio succitato, assume qui un ulteriore significato: l’idea di una fruizione disincarnata già prodotta dallo spazio della galleria – che rende il corpo “superfluo, un’intrusione”[7] – si realizza compiutamente sullo schermo, nel quale “gli occhi e le menti sono accettati, i corpi che occupano spazio non lo sono”[8].
Difficile valutare in questo momento ‒ e in questa sede ‒ quale traiettoria seguirà il paradigma della fiera dopo queste vicende. Con ogni probabilità, il carattere mediato resterà un punto determinante, indirizzando l’attenzione a una sempre maggiore integrazione fra dimensioni diverse.
[1] Brian O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, The Lapis Press, Santa Monica-San Francisco, 1986, p. 15.
[2] Thomas McEvilley, Introduction, in Brian O’Doherty, op. cit., p. 7.
[3] Christine Mehring, Emerging Market, in “Artforum International”, April 2008, vol.46, no.4, p. 322.
[4] Ibid., p. 325.
[5] Ibid., p. 327.
[6] Brian O’Doherty, op. cit., p. 14.
[7] Ibid., p. 15.
[8] Ibid.
Autore
Romuald Demidienko

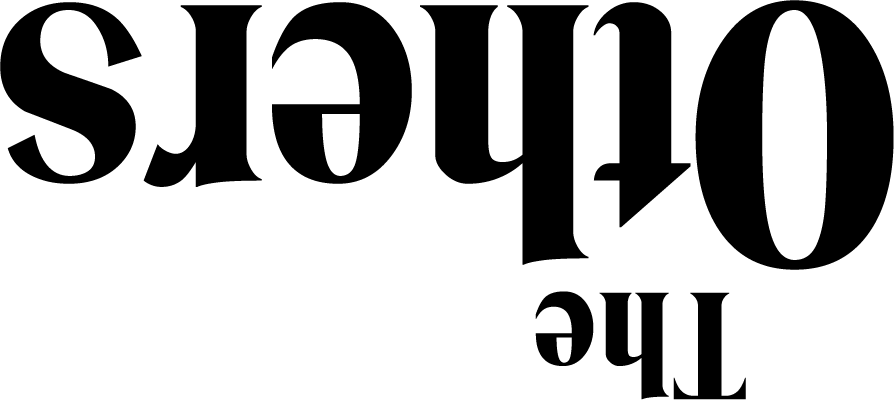

Sorry, the comment form is closed at this time.